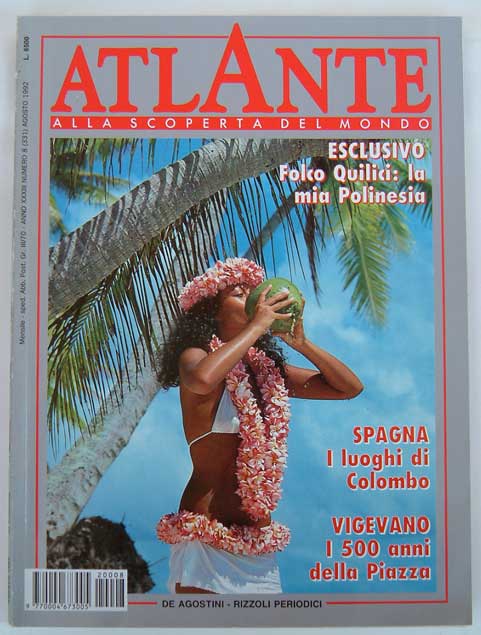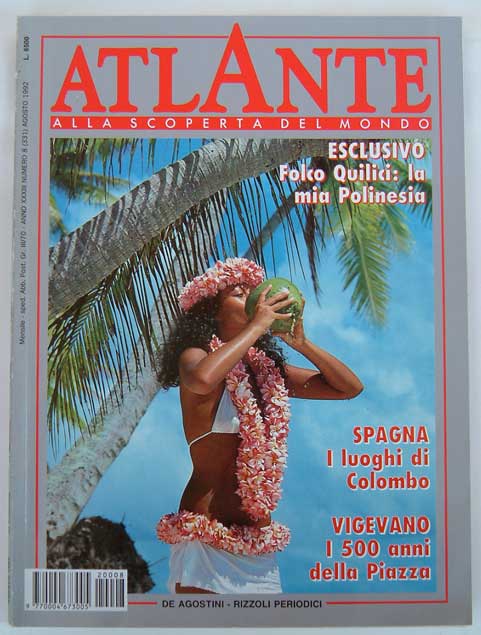IN
AUTO DAL MAINE ALLA FLORIDA
Articolo premiato alla
1a
Edizione dei USA Media Awards,
organizzata dal Visit USA Committee.
Riconoscimento Speciale per Originalità e
Destinazione Insolita
Sezione Giornalismo
|
|
Pubblicato
sul n. 337 della rivista ATLANTE
(Febbraio / Marzo 1993)
Cara,
vecchia
NUMERO 1
ERA
UNA
PISTA INDIANA LA PIÙ VECCHIA
STRADA DEGLI STATI UNITI.
LUOGHI
E PERSONAGGI LUNGO I 3.970
CHILOMETRI DELLA “U.S. ONE”.
UN FANTASTICO VIAGGIO IN
AUTO DAL GELO DEL MAINE AL SOLE
DELLA FLORIDA
Testo:
Guido
Zurlino - Foto:
Andrea Pistolesi
 
Quando vidi finalmente le onde
dell’oceano che si abbattevano contro
la costa scura e frastagliata del
Maine non riuscii a trattenere un
sospiro di sollievo. Per un attimo
pensai all’Anabasi di Senofonte, poi
il ricordo del grido di sollievo dei
soldati greci alla vista del mare
svanì come la nebbia sottile che mi
circondava e immaginai di essere già
in prossimità di Key West. In realtà,
l’isola resa famosa da Hemingway e
dalle sue battute di pesca al marlin
si trovava quasi 4.000 chilometri più
a sud, ma dopo aver guidato per un
giorno lungo il confine tra Stati
Uniti e Canada in un interminabile
tunnel di fiocchi di neve scagliati
contro il parabrezza da violente
raffiche di vento, anche la visione di
un mare gelido come quello della Baia
di Passamaquoddy può creare strane
associazioni mentali.
Ero entrato negli Stati Uniti
all’alba, calandomi nel Maine dalla
provincia canadese del New Brunswick,
e la prossimità del Québec si era
fatta sentire ancora per qualche ora.
Le insegne dei negozi ammiccavano in
francese, le pompe delle stazioni di
servizio calcolavano la benzina sia in
galloni sia in litri, e di tanto in
tanto l’autoradio captava i programmi
francofoni destinati ai villaggi
che sfilavano in successione a
poche centinaia di metri da me,
sull’altra sponda del fiume ghiacciato
che segnava il confine con il Canada.
Almeno in un dettaglio i notiziari in
entrambe le lingue concordavano. Le
condizioni del tempo. Che “11,4
sottozero” diventassero
miracolosamente “11,4 sopra” da questa
parte del nastro perlaceo del
Madawaska River dipendeva solo da una
bizzarra concidenza tra le scale
termometriche Celsius e Fahrenheit. In
realtà i due rilevamenti indicavano la
stessa temperatura polare e la morsa
del gelo era resa ancora più feroce da
un “wind-chill factor” (fattore vento)
di meno venti gradi, che sottoponeva
ogni centimetro di epidermide esposta
a un autentico test di resistenza
artica.
“Un
americano si costruisce la casa per
la vecchiaia e la vende prima della
posa del tetto, trova lavoro e lo
cambia, si insedia in un’area e
presto l’abbandona per trasferirsi
ad almeno cinquecento miglia di
distanza.” Così Alexis de
Tocqueville descrisse più di un secolo
e mezzo fa l’inclinazione del popolo
americano ai grandi spostamenti. Da
allora, immagini come un convoglio di
carri nella prateria, due fari nella
notte riflessi sull’asfalto bagnato,
un autostoppista solitario sono
diventati temi classici della cultura
di questo paese, una sorta di
ossessione della strada riproposta
dalla letteratura e dal cinema in una
linea di continuità tra la
disperazione dei contadini di John
Steinbeck, gli Okies di Woodie
Guthrie, e la moderna ingenuità dei
protagonisti di Easy Rider e Thelma
& Louise. Nel mio caso, la
lunga pista da percorrere “fino alla
fine” era la mitica U.S. Highway One,
ovvero la strada più antica degli
Stati Uniti.
Era un viaggio che sognavo spesso
quando vivevo nel nord del New
England, dove l’inverno dura cinque
mesi e si sente ancora parlare di
Cabin Fever, la sindrome depressiva
che assaliva i pionieri nelle loro
capanne di tronchi semisepolte dalla
neve. Da quelle parti
nacque la leggenda di Paul Bunyan, il
gigante-boscaiolo delle grandi foreste
del Nord che compie imprese
paradossali assieme a Babe, il suo
inseparabile bue azzurro (naturalmente
per il gran freddo). Trovavo
stimolante che la “U.S One” ricalcasse
antiche piste indiane e fosse
punteggiata di ricordi storici, ma
soprattutto mi affascinava che dopo
aver attraversato quattordici stati la
sua corsa si concludesse a Key West,
in Florida, nel punto più meridionale
degli Stati Uniti. Il solo nome del
Sunshine State, “lo Stato del Sole”,
evocava in me immagini di evasione in
un paradiso terrestre, con alte palme
frondose e lunghe spiagge di sabbia
bianca sullo sfondo di un caldo mare
subtropicale.
Anche Anne, l’agente della
polizia doganale che qualche ora prima
aveva controllato il mio passaporto
sul ponte di Fort Kent, doveva aver
provato lo stesso desiderio di fuga.
“Durante la stagione fredda qui è
tutto morto” mi aveva detto accennando
col capo alla bianca fissità dello
scenario. “A Natale le stazioni
sciistiche sono gremite di turisti, ma
per il resto dell’inverno persino le
ville dei professionisti di Boston e
New York rimangono sbarrate. Nessuno
esce di casa e gli unici business che
‘tirano’ sono le videocassette a luci
rosse e i superalcoolici”.
Sessant’anni fa i suoi colleghi erano
saliti agli onori delle cronache
lottando contro gli importatori
clandestini di booze (liquori) dal
Canada, ma poi l’abrogazione del
proibizionismo trasformò Fort Kent in
una semplice macchia sulle carte
stradali. Oggi sul suo ponte non
transitano più finti funerali con le
bare e le auto del seguito imbottite
di bottiglie, ma al massimo qualche
frontaliero che va a fare la spesa
oltreconfine. Restituendomi
il documento, Anne si era stretta
nelle spalle con un sorriso. Il suo
cognome francese tradiva la
discendenza da una delle famiglie
dell’Acadie esiliate dalla Nuova
Scozia dopo il rifiuto di giurare
fedeltà alla corona britannica ma
ormai l’unico segno visibile di
quell’antico spirito ribelle erano i
fiorellini colorati che esibiva sul
calcio di madreperla della pistola
d’ordinanza.

Seguire la costa del Maine lungo la
“U.S. One” significa dimenticarsi per
lunghi tratti della presenza dell’uomo
ed entrare a contatto con la forza
della natura. Per avere un’idea
dell’enorme varietà del paesaggio
basta considerare che Eastport e
Portsmouth distano in linea d’aria
solo 370 chilometri ma le miriadi di
insenature rocciose, baie, calette e
fiordi che scolpiscono il litorale
compreso tra queste due città si
sviluppano per oltre 5.600 (più di
tutta l’Italia peninsulare!). Il
tratto della “One” che collega i due
porti si snoda per 580 chilometri
senza mai allontanarsi troppo da
quella che i geologi definiscono una
costa “sprofondata”. Nei punti più
selvaggi la vegetazione è tipicamente
nordica. Lunghe file di betulle dalla
sottile corteccia bianco-argentata si
alternano agli olmi sopravvissuti
all’epidemia di inizio secolo, e di
tanto in tanto un faro interrompe
l’orizzonte. Tra le curiosità stampate
sul menù di un ristorante per
camionisti presso Kennebunkport leggo
che la superficie del Maine è maggiore
di quella degli altri cinque stati del
New England messi assieme, mentre la
sua popolazione è inferiore persino a
quella del minuscolo Rhode Island. Più
tardi, assaporando una clam
chowder bollente (la zuppa di
vongole locale) nell’attesa di
un’ottima aragosta della Baia di
Penobscot (in tutto quindici dollari e
settantacinque, vino e mancia
compresi), ricorderò che Stephen King
è nato e vive nelle vicinanze. Che si
sia ispirato alla bellezza e alla
solitudine di questi paesaggi
spettrali per scrivere il suo
“Misery”?
A chi sa abbastanza di America, il
nome Salem ricorda decine di romanzi
gotici e film dell’orrore ambientati
sullo sfondo di questa cittadina del
Massachusetts, ma recentemente due
newyorchesi che partecipavano a un
quiz televisivo non sono riusciti a
far meglio che associarlo all’omonima
marca di sigarette. Un terzo
concorrente ha inaspettatamente
ricordato che qui nacque Nathaniel
Hawthorne (quello della Lettera
Scarlatta), ma neanche lui sapeva che
il toponimo deriva da “shalom”, un
termine ebraico che significa pace. A
dispetto del nome, l’atmosfera che
regnava qualche secolo fa nell’antico
villaggio non doveva sembrare affatto
tranquilla, soprattutto agli occhi
delle vittime dell’ondata di isteria
collettiva che raggiunse il culmine
nel 1692. Erano trascorsi esattamente
duecento anni dalla serendipità di
Colombo e i figli dei Padri Pellegrini
stavano ancora “plasmando” la
Nuova Inghilterra
anzichè limitarsi a
colonizzarla. In quella “vecchia”, i
loro antenati calvinisti si erano
scontrati con l’atteggiamento
tollerante di Giacomo I nei confronti
dei Papisti, sentendosi costretti,
come sottolineò Artemus Ward “ad
abbandonare una nazione dispotica per
un paese libero, dove coltivare
liberamente le loro idee religiose...
ma soprattutto impedire agli altri di
esprimere le proprie”. Fustigazioni,
gogne, processi sommari erano
all’ordine del giorno in quello che
più tardi sarebbe diventato il più
democratico degli States (se non altro
nel senso del partito), tanto che il
Re dovette intervenire personalmente
affinché si riducessero le
impiccagioni dei quaccheri nei
giardini pubblici di Boston. In tale
clima di paura e intolleranza era
prevedibile che le favole voodoo
raccontate ai bambini del vicinato da
una schiava di Barbados incontrassero
la disapprovazione dei benpensanti.
Quando poi due cuginette
particolarmente suggestionabili
cominciarono a soffrire di convulsioni
(forse per aver mangiato pane
contaminato da funghi allucinogeni) e
accusarono alcune vicine di aver
gettato su di loro il Malocchio, si
scatenò il finimondo. Nel giro di
quattro mesi, diciannove persone (e
due cani) finirono sul patibolo con
l'accusa di stregoneria. Un ventesimo
sventurato che non si decideva a
dichiararsi né colpevole né innocente
morì soffocato da un mucchio di pietre
durante un interrogatorio, liberando i
giudici dall’ardua scelta tra
condannarlo all’impiccagione, come gli
altri rei confessi, o al rogo, come
chiunque rifiutasse “diabolicamente”
di ammettere le proprie colpe.
L’opportunità di visitare i luoghi
testimoni di quei tragici avvenimenti
nella ricorrenza del trecentesimo
anniversario è stimolante, anche se
devo abbandonare momentaneamente la
“One” dopo il confine tra New
Hampshire e Massachusetts e allargare
verso la costa per una ventina di
chilometri. È inverno pieno e
l’invasione turistica prevista con
l’arrivo della bella stagione è ancora
lontana. La gente del posto mi passa
accanto con indifferenza, ma non è
facile dimenticare un passato
imbarazzante quando le autorità
municipali hanno puntato tutto sulla
sua rievocazione. A ogni angolo,
manifesti e locandine propongono
visite guidate al tribunale
dell’epoca, allegre escursioni in tram
alla “Collina del Capestro”, itinerari
delle case delle vittime... e c’è
persino un suggestivo Museo delle
Streghe, dove ogni mezz’ora viene
messa in scena una realistica
rappresentazione dei processi. Mentre
sto per ripartire, una coppia di
turisti giapponesi mi prega di
riprenderli con la loro Nikon. Nulla
di più eccitante di una foto ricordo
davanti ai sinistri frontoni coloniali
della casa in cui il famigerato
giudice Corwin “interrogava” i
sospetti.
Se non fosse per una piazza
“particolare”, la cittadina di Lowell
in Massachusetts (97.249 abitanti nel
1950, 94.239 nel 1970, 92.418 nel
1980), sarebbe identica a tanti altri
piccoli centri ormai decaduti della
provincia americana. Una periferia
esterna di casette di legno con la
vernice che si scrosta dalle pareti
delle verande. Una periferia interna
di vecchie fabbriche abbandonate, con
le ciminiere in mattoni rossi,
testimonianze sbrecciate di un passato
industriale neppure troppo recente. Un
downtown anonimo con gli immancabili
supermercati, il negozio di ferramenta
e una banca aperta anche il sabato
mattina. I pochi operai in strada
prima dell’alba indossano giacconi a
scacchi, berretti con i paraorecchi e
vecchie Timberland acquistate prima
che dall’altra parte dell’oceano
perdessero la loro identità di
calzature da lavoro e il loro prezzo
raddoppiasse. Dietro una curva, la
strada si allarga nella Eastern Park
Plaza, anch’essa anonima, eppure, per
qualche romantico viaggiatore come me,
diversa tra tante altre uguali. Su
un’area rialzata rispetto al piano
stradale individuo i blocchi di marmo
che stavo cercando. Sono neri, lucidi,
quadrangolari, poco più alti di un
uomo. Sui lati di questi monoliti,
come tante steli funerarie, sono
incisi i titoli e le prime righe di
una diversa opera letteraria, in tutto
una manciata di testi.
“Quando
incontrai Dean per la prima volta mi
ero appena separato da mia moglie”
recita in inglese la prima lastra
levigata. È l’incipit di On the Road
(Sulla strada), il libro sacro del
movimento beat, che a partire dagli
anni ’60 ha spinto milioni di
viaggiatori lungo le strade di tutto
il mondo. In rapida successione, lo
sguardo scorre gli altri titoli:
“Vanity of Duluoz”, “The Dharma Bums”,
“The Subterraneans”, “Maggie
Cassidy”... Su un blocco, lo scalpello
ha inciso a lettere maiuscole un nome
e due date: “Jack Kerouac - 1922 -
1969”. Chissà se i Cassidy abitano
ancora al 31 di Massachusetts Street?


Nella capitale pioviggina e le pale di
un elicottero militare che sorvola il
Vietnam Memorial diretto al Pentagono
rompono il silenzio con il loro
pulsare ritmico, creando un clima da
Apocalypse Now. “Dopo venticinque anni
mi fanno ancora rabbrividire” mormora
sorridendomi un uomo stempiato di
fronte a un monumento che raffigura
tre marine. “Sono riprodotti in modo
perfetti, amico. Guarda per
esempio le piastrine infilate negli
stivali” (le chiama dog-tags, come le
medagliette dei cani) “Le ficcavamo lì
perché era più comodo. E la bandoliera
attorno alle spalle? Io i proiettili
li rivolgevo verso il basso, lontano
dal viso.” Si chiama Carl e lavora in
un centro di riabilitazione per
reduci, dove viene quotidianamente a
contatto con la realtà di un conflitto
che per molti non è mai finito. A
venti metri da noi, come una lunga
cicatrice nera sull’erba, c’è il muro
con i nomi degli oltre 58mila caduti
in Vietnam, e a meno di un chilometro
scorre la “One”, puntuale anche a
questo appuntamento con la storia
americana. Là mi aspetta un altro
simbolo di questo Paese: la nuova
Cadillac che ho noleggiato arrivando
nella capitale. L’altra auto aveva il
riscaldamento bloccato sulla posizione
MAX, ma me ne sono accorto solo
uscendo dal grande freddo del Nord.

In un anno, un americano percorre
in media 12.500 chilometri al volante.
Negli ultimi sei giorni ho guidato per
2.500 chilometri e sono appena a metà
strada del mio viaggio. La Florida è
ancora lontana, ma oltre il Potomac si
respira già aria di “Vecchio Sud”. La
One rinuncia ad assomigliare a una
Highway e assume sempre più
frequentemente l’aspetto di un vialone
rurale, sfiorando assolati campi di
battaglia della guerra civile e aie di
vecchie cascine costruite prima che
Ford democratizzasse l’automobile. In
un solo anno il suo “Model T” fu
acquistato da un milione e mezzo di
americani e avviò il processo di
ampliamento della rete stradale
nazionale, ma come ogni rivoluzione,
anche questa pretese le sue vittime.
Arthur B. è l’anziano proprietario di
una vecchia stazione di servizio sulla
“Route One”, nel sud della Virginia,
costretto a trasformare il suo
“general store” in una bottega di
robivecchi quando la lunga arteria
divenne insufficiente ad accogliere il
grande traffico e le fu costruita
accanto la più veloce Interstate 95 (a
pagamento). “Per me la recessione è
cominciata trent’anni fa, quando i
mostri se ne sono andati a est” dice,
riferendosi ai giganteschi camion e
alla moderna autostrada che scorre a
un paio di chilometri. “Da allora
trascorro le giornate ascoltando con
il C.B. le conversazioni dei
camionisti sulla “95” e servo qualche
automobilista distratto che ha
sbagliato uscita.” Dietro pile di
libri polverosi, vecchi giocattoli che
evocano sogni infantili, e
storiche copie di Playboy accatastate
sul pavimento, occhieggiano curiosi
alcuni gattini. Ninnoli pseudo-liberty
e barattoli ammaccati ricoprono gli
scaffali. Fuori, un’oca ben pasciuta
passeggia tra le pompe arrugginite, e
dalle crepe dell’asfalto spuntano
ciuffi d’erba. La One è deserta, ma
non mi stupirei se da un momento
all’altro apparisse uno sgangherato
pick-up con Jack Nicholson al volante.
Lungo i monti Appalachi, il postino
non ha ancora suonato per la seconda
volta.
 |
|
 |
Chi pensa che non esista un’autentica
gastronomia americana potrà ricredersi
visitando gli stati del sud, dove le
grandi tradizioni culinarie sono
addirittura due: la “creola” e la
“cajun”. La prima fu divulgata dalla
cuoca di un governatore che aveva
appreso dagli schiavi l’uso dell’okra, e
costituisce la base della raffinata
alimentazione urbana. La seconda
(sebbene derivi dal francese acadien,
cajun si pronuncia con l’accento sulla
prima sillaba) è essenzialmente una
cucina rurale, caratterizzata da
preparazioni laboriose e gusti piccanti.
Attraversando la Carolina del Sud e la
Georgia c’è l’imbarazzo della scelta tra
tanti punti di ristoro che assomigliano
al Whistle Stop Café di Pomodori
Verdi Fritti ma dove l’atmosfera,
le torte alle noci pecan e l’accento
yawl sono ancora quelli dei tempi di Via
col Vento. Per chi non disdegna la
musica di Zachary Richard e di gruppi
come i Beau Soleil - e soprattutto per
chi si adegua all’uso locale di ordinare
grits (farina d’avena) con le
uova e hush puppies (crocchette
salate) con i piatti di pesce - la
soddisfazione è garantita.
Sono passati
cinque secoli da quando una freccia
indiana fermò Ponce de Lèon nella
ricerca della fontana della
giovinezza, ma ancora oggi quel mito
viene rinnovato da migliaia di
pensionati che si trasferiscono in
Florida sperando che l’eterna estate
li faccia tornare giovani. Tutto
cominciò alla fine del secolo scorso
con la ferrovia del lungimirante Henry
Flagler, ma il vero boom
dell’immigrazione di massa si è
verificato negli ultimi quattro
decenni, determinando una
singolarissima situazione demografica.
Senza gli anziani che scendono dal
nord a un ritmo di 15/18.000 al mese,
la Florida sarebbe meno popolata del
Minnesota, mentre già ora i suoi
abitanti superano quelli del Nord
Dakota, del Sud Dakota e del Nebraska,
più tutti quelli del Minnesota. Ma
senza di loro, l’età media scenderebbe
a 25 anni (contro i 36 attuali) e
l’indice di mortalità si abbasserebbe
del 16%, assestandosi ai livelli del
resto della nazione. Un dato
impressionante, che se da una parte ha
fatto guadagnare allo stato il
soprannome di “patria di prossimi
morituri”, dall’altra ne ha foraggiato
le casse al punto da consentire un
sistema fiscale esente da tasse sul
reddito e imposte fondiarie e di
successione minime o inesistenti. Di
conseguenza, moltissimi giovani
vengono qui a cercare impiego nelle
strutture di servizi per la terza età,
creando le premesse per un’industria
del divertimento dedicata alle loro
esigenze... la quale a sua volta
attira ogni anno 35 milioni di turisti
di ogni età. E il ciclo ricomincia.
St. Augustine è la più vecchia città
degli Stati Uniti ed è anche la
località dove mi riavvicino
all’Atlantico dopo averlo lasciato
dieci stati fa, nel Connecticut.
L’unica differenza è che qui splende
il sole e ci sono venticinque gradi in
più. La fortezza che domina la baia,
le tegole in cotto sulle chiese
bianche di calce e le persiane verdi
nei vicoli ombreggiati da palme e
mangrovie testimoniano le origini
spagnole della città e non fanno
rimpiangere l’essenzialità
presbiteriana della vicina Georgia. Da
qui a Miami mi aspettano 500
chilometri di sogno: spiagge spaziose,
pulite, e soprattutto libere. Il
turchese del mare e lo spettro della
luce sono di quelli che non creano
problemi neppure agli esposimetri più
permalosi, mentre la temperatura
dell’acqua è garantita dalla Corrente
del Golfo, così calda che in estate
persino gli squali preferiscono
risalire verso le coste
settentrionali. Io invece punto
diritto a sud, anzi, verso il punto
più meridionale della città più
meridionale degli USA, ignorando
località dai nomi seducenti come
Daytona, Orlando, Disneyworld, Cape
Canaveral, Palm Beach, Boca Raton, e
persino Fort Lauderdale e Miami Beach
con i loro concorsi di Miss Spiaggia e
Mini-Bikini, nella fretta di
raggiungere l’ultimo dei cartelli con
il numero “1” che indichi la fine del
mio viaggio. Ne ho incontrati
centinaia da quel lontano “Zero Mile”
di Fort Kent, anticipando ogni volta
il momento conclusivo di questa
avventura di 3.970 chilometri. Più o
meno la distanza stradale tra Madrid e
Atene.
In sintonia con
le tante curiosità che la
caratterizzano, Key West è l’ultima e
anche la più famosa di un pugno di
keys (dallo spagnolo cayo, isoletta)
che si protendono nel Golfo del
Messico lungo un sottile arco
corallino di 200 chilometri. Per
raggiungerla occorre superare con
spettacolari balzi panoramici i 42
ponti della “Route One”, che in questo
tratto prende il nome di Overseas
Highway - la strada sull’acqua più
lunga del mondo. Sebbene siano
identificate da un’unica denominazione
geografica, le keys si differenziano
per cultura e tradizioni e presentano
grandi divari tra lo stile di vita
moderno di quelle settentrionali e la
tranquilla esistenza dei conch
nativi delle isole inferiori, scandita
dai lenti ritmi della natura. L’ora
migliore per arrivare a Key West è il
tardo pomeriggio, giusto in tempo per
unirsi alla piccola folla di turisti
che esce da bar pittoreschi come lo
Sloppy Joe’s (dove Hemingway “beveva e
faceva a pugni”) e si reca al Mallory
Pier per assistere al tramonto del
sole: un rito quotidiano così
importante che la radio locale
diffonde l’ora esatta dell’avvenimento
e le previsioni metereologiche sulla
sua spettacolarità. Il clima è quello
dell’America anni ’70, con giocolieri,
mimi, musicisti, hippy vecchi e nuovi
che si abbandonano a scroscianti
applausi quando la gigantesca palla
infuocata sprofonda nel mare color
cobalto. La Giamaica non è lontana, ma
l’odore di erba bruciata che sento
nell’aria proviene da molto più
vicino. In tono più moderato, la
stessa cerimonia ha luogo al
Southernmost Point, dove il pubblico è
formato da romantiche coppiette e
silenziosi adoratori del sole. Un
cippo dipinto a mano avverte che
questo è il punto più meridionale
degli Stati Uniti e mi rammenta che
Cuba dista “soltanto” 90 miglia (145
km). Reminiscenze della guerra fredda!
E la Route One? Muore in fondo a
Truman Avenue, discretamente come è
nata presso quel lontano ponte di Fort
Kent, lassù nel Maine. Ma al mio
arrivo non trovo nessun cartello
“Zero”, perché il solito collezionista
di souvenir l’ha rubato. Domani
mattina, puntuale come il sole che
sorge ogni giorno sull’Highway One, la
squadra addetta alla manutenzione avrà
già provveduto a rimpiazzarlo.
Guido
Zurlino
 
|
|
|